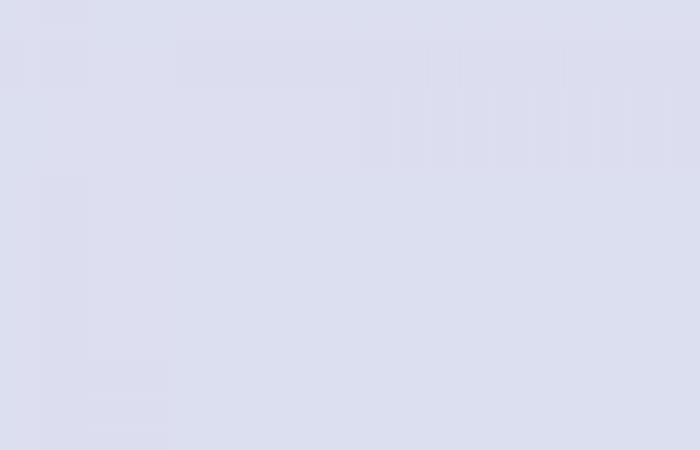Di Collot JULIEN, David BARATOUX, Pierre-Yves LE MEUR, Sarah SAMADI*.
Conosciamo davvero meglio il nostro pianeta o Marte? Questa domanda può sembrare assurda, ma se siamo in grado di mappare l’intera superficie del pianeta rosso, tutta una parte della nostra ci è quasi sconosciuta: il fondale oceanico. L’esplorazione è una delle forze trainanti della scienza e anche sul nostro pianeta abbiamo ancora tanto da scoprire.
Il mare profondo e lo spazio sembrano essere le ultime frontiere dell’umanità. Questi oggetti distanti e difficilmente accessibili affascinano, al di là delle loro differenze. È vero che conosciamo lo spazio meglio dei fondali marini? Come li esploriamo e in risposta a quali motivazioni? Ciò che sappiamo o non sappiamo dipende sia dai mezzi utilizzati (come guardiamo) sia dalle domande che ci poniamo (cosa guardiamo o cerchiamo). Queste domande si riferiscono alla vocazione esplorativa della scienza che la sua attuale burocratizzazione tende a farci dimenticare.
La Terra è coperta per il 70% da oceani con una profondità media di 3.700 m. Guarda con una maschera dalla superficie, vedrai il fondale solo se ci sono meno di 10 m d’acqua, guarda il cielo, i fotoni che ti raggiungono potrebbero aver attraversato milioni di anni luce! L’acqua è la principale barriera alla conoscenza dei fondali marini: le onde elettromagnetiche (luce, laser, onde radio) vengono lì assorbite molto rapidamente, mentre si propagano per immense distanze nello spazio.
Conoscenza parziale dei fondali marini
Possiamo quindi caratterizzare gli oceani solo indirettamente dalle navi, utilizzando ecoscandagli acustici o prelevando campioni ottenuti utilizzando strumenti sospesi ad un cavo. Occasionalmente utilizziamo sommergibili con equipaggio o robotici che osservano solo da una decina di metri attorno a loro utilizzando potenti proiettori. Nel 2023, solo il 25% dei rilievi dei fondali marini era stato mappato utilizzando metodi acustici.
Questo tipo di nave che consente la mappatura si muove solo a 5 km/h, quindi ci vorrebbero tre secoli per coprire completamente il fondale marino a questa velocità. Negli anni ’90 un nuovo metodo ha permesso di stimare approssimativamente la profondità degli oceani a partire da piccole variazioni dell’altitudine della superficie dell’acqua, misurata dai satelliti (altimetria). Queste sono le mappe che consultiamo in Google Earth.
Leggi anche: L’Atlantico potrebbe perdere le sue “supercorrenti”, ecco gli sconvolgimenti da aspettarsi
Ovunque guardiamo, scopriamo organismi originali. L’esplorazione delle profondità marine, ad esempio, rivela animali viventi i cui parenti più stretti sono animali fossili – quindi estinti – conosciuti da tempo negli strati sedimentari dei continenti! Alla fine degli anni ’70 si scoprì inoltre che non è solo la fotosintesi la fonte primaria della materia vivente. Così, ai piedi di profonde bocche idrotermali, che emettono fluidi caldi e “tossici”, proliferano oasi di vita grazie a batteri chemiosintetici capaci di produrre materia organica senza luce. Da allora la chemiosintesi è stata osservata anche in ambienti costieri ma anche sulla terraferma e addirittura nell’atmosfera!
Leggi anche: È stato scoperto un deposito di carbonio nel mezzo del Pacifico, perché è una buona notizia?
La scoperta dello spazio
Per quanto riguarda lo spazio, l’invio della sonda sovietica Luna 1 nel 1959 segnò l’inizio dell’esplorazione spaziale del Sistema Solare. 60 anni dopo, gli otto pianeti del Sistema Solare sono stati tutti visitati da una sonda spaziale, così come i più grandi satelliti dei pianeti giganti. Queste sonde hanno prodotto immagini di paesaggi extraterrestri, inabitabili, ma incredibilmente vari.
Leggi anche: Missione Artemide. Cosa abbiamo inviato sulla Luna dagli anni ’60?
L’esplorazione con telecamere spaziali si è presto arricchita di strumenti che permettono di mappare la natura dei materiali (composizione chimica, mineralogica, ricerca di molecole organiche) mentre si sviluppa l’esplorazione in situ (lander, poi veicoli rotanti e, molto recentemente, un piccolo elicottero), per una mobilità sempre maggiore per l’esplorazione. È possibile produrre mappe geologiche di qualsiasi pianeta rosso senza che nessun uomo abbia messo piede sul suo suolo.
La nostra conoscenza del sistema solare proviene anche dai meteoriti, strappati via dalle collisioni (impatti) e che terminano il loro viaggio interplanetario sulla superficie del nostro pianeta. Le missioni spaziali sono dedicate anche alla raccolta di campioni. È stato il caso delle missioni Apollo sulla Luna, e più recentemente della missione OSIRIS-REx che è riuscita a riportare sulla Terra un campione dell’asteroide Bennu. Presto sarà il turno di Marte.
Le sonde spaziali hanno raggiunto distanze considerevoli. La sonda New Horizons, dopo aver sorvolato Plutone, si è spinta fino ai confini del Sistema Solare (a più di 6 miliardi di km dalla Terra) per fornire immagini di un piccolo asteroide (Arrokoth) a forma di pupazzo di neve che ci racconta i primi istanti della formazione dei pianeti. Ma c’è ancora molto da esplorare, alla ricerca di ambienti magari abitabili. Migliaia di corpi nel sistema solare (asteroidi, piccoli satelliti di pianeti giganti) sono conosciuti solo dalla luce che riflettono dal Sole.
Leggi anche: Cosa nasconde il lato nascosto della Luna?
Le distanze coperte sembrano già immense, ma nessuna sonda spaziale costruita dall’uomo ha davvero lasciato la zona d’influenza del Sole, anche se Voyager 1 e 2 sono effettivamente in viaggio verso il mezzo interstellare. Per raggiungere la stella più vicina a noi non dobbiamo percorrere pochi miliardi di chilometri, ma 40.000 miliardi! Al momento non ci è possibile esplorare direttamente lo spazio oltre il sistema solare se non attraverso la luce che ci rimandano gli oggetti che popolano l’universo.
Ulteriori esplorazioni
In termini di cartografia è corretto dire che conosciamo la superficie delle stelle del sistema solare meglio del fondale marino. Le risorse destinate ai primi sono maggiori (2 miliardi di euro sono stati destinati all’esplorazione spaziale in Francia nel 2020, contro 0,4 miliardi per i fondali oceanici). Al di là del Sistema Solare, le capacità tecnologiche permettono di vedere alcuni dettagli sulla “superficie” delle stelle e di rivelare la natura rocciosa o gassosa degli esopianeti, ma siamo molto lontani dall’aver mappato le centinaia di miliardi di oggetti che popolano il nostro pianeta. galassia.
Leggi anche: Quiz. Quanto conosci il nostro sistema solare?
Va riaffermato qui che la scienza è in gran parte una questione di esplorazione ed è essenziale coltivare questa dimensione fondamentale. Questa esplorazione è strettamente legata alla ricerca delle origini della vita, anche se anche altre questioni, economiche o geopolitiche, motivano questa ricerca. Le molecole organiche scoperte al di fuori del nostro pianeta o i processi bio e geologici individuati negli ambienti oscuri dei fondali marini mettono in discussione la capacità della vita di svilupparsi altrove e ovunque nell’universo.
L’esplorazione dello spazio e dei fondali marini non sono contrapposti, sono complementari, e si alimentano a vicenda per comprendere le nostre origini, ripensare il nostro presente e progettare il nostro futuro!
La versione originale di questo articolo è stata pubblicata in La conversazione.
* Riguardo agli Autori : Collot Julien, docente-ricercatore in geoscienze marine, Università della Bretagna Occidentale; David Baratoux, geologo, presso l’Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD); Pierre-Yves Le Meur, antropologo, ricercatore principale dell’IRD e Sarah Samadi, professoressa di biologia evoluzionistica al Museo Nazionale di Storia Naturale (MNHN).