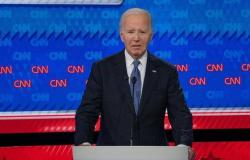Gli obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra sono decisi a livello dell’Unione Europea (UE). È stato quindi il Consiglio dei Capi di Stato ad adottare l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 55% tra il 1990 e il 2030 per puntare alla neutralità nel 2050, decisione poi tradotta in legge dai deputati uscenti del Parlamento europeo.
L’UE svolge anche un ruolo cruciale nell’attuazione delle politiche climatiche. Gli standard normativi, come quello ampiamente discusso dai candidati sul divieto di vendita di nuove auto termiche dal 2035, sono europei. Infine, è l’UE ad avere il controllo sul sistema di scambio delle quote di CO2, in gran parte assente dai dibattiti nonostante il suo ruolo nella riduzione delle emissioni.
Per comprendere meglio le questioni climatiche legate alle elezioni, esaminiamo a che punto si trova l’UE in termini di riduzione delle emissioni e le leve a sua disposizione per raggiungere l’obiettivo del -55%.
L’impronta di carbonio dell’UE sta diminuendo, ma non abbastanza velocemente
Nel 2023, le emissioni lorde dell’UE (misurate escludendo il sequestro di CO2 dalle foreste) sono diminuiti di un terzo rispetto al 1990. Contrariamente a quanto si crede, questo calo non è dovuto allo spostamento delle emissioni di CO2 che reimporteremmo tramite l’acquisto di prodotti emittenti da paesi terzi. Dal 2005, l’impronta dei consumi dell’UE, che include queste emissioni incorporate nelle importazioni, è diminuita allo stesso ritmo delle emissioni all’interno dell’UE.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Se ci sono voluti 33 anni per ridurre le emissioni del 33%, raggiungere il -55% nei restanti 7 anni entro il 2030 è un obiettivo raggiungibile? Dobbiamo infatti distinguere due periodi:
- Le emissioni dell’UE sono rimaste stagnanti tra il 1990 e il 2005.
- Dal 2005 seguono una tendenza al ribasso del 2% annuo, una volta eliminate le fluttuazioni a breve termine.
Agenzia europea dell’ambiente (stima provvisoria per il 2023), Fornito dall’autore
La causa di questa rottura di tendenza è chiaramente identificabile. Il 2005 segna l’avvio effettivo delle politiche europee sul clima, con l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e del sistema di scambio delle quote di CO2.
Per raggiungere l’obiettivo del -55%, questo tasso tendenziale di declino dovrà essere raddoppiato entro il 2030. Questo è l’obiettivo della gamma di misure del “Green Deal” e delle loro variazioni settoriali. Se contestiamo queste misure, cosa che ovviamente è un diritto di tutti in una democrazia, dovremo offrire dei sostituti oppure abbandonare l’obiettivo del -55%. È in questi termini che va organizzato il dibattito pubblico.
Energia e industria in prima linea, i trasporti in ritardo
Due settori, la produzione di energia (elettricità, calore, raffinazione del petrolio) e l’industria, hanno ottenuto l’80% della riduzione delle emissioni (vedi tabella sotto). Sono questi i settori coperti dal sistema di scambio delle quote, la cui riforma costituisce un anello essenziale del Green Deal.
Un prezzo elevato per la quota di CO22 accelera la chiusura delle centrali elettriche che utilizzano carbone o altri combustibili fossili. L’eliminazione delle assegnazioni gratuite di quote ancora concesse all’industria manifatturiera, insieme alla carbon tax alla frontiera, dovrebbero facilitare la decarbonizzazione dei processi industriali più inquinanti proteggendo i settori interessati (acciaio, cemento, fertilizzanti, ecc.) dalla concorrenza paesi terzi.
Tuttavia i candidati sono favorevoli alla tassa alle frontiere, ma trascurano altri aspetti della riforma del mercato delle quote di CO22.
premio Elezioni europee: perché le urne hanno mancato tre eventi chiave del 2019
Le emissioni generate dai trasporti – un quarto del totale, un terzo se includiamo i trasporti internazionali – sono ancora significativamente superiori ai livelli del 1990. È in questo settore che è imperativo trovare riduzioni delle emissioni aggiuntive entro il 2030 affrontando il trasporto su strada. principale fonte di emissioni di CO22 settore, ma anche trasporto aereo e marittimo.
L’elettrificazione dei veicoli, destinata ai nuovi veicoli secondo gli standard europei, è solo uno dei vettori di questa trasformazione. Bisognerà giocare anche sulla condivisione tra trasporti individuali e collettivi, sulla velocità degli spostamenti, sul loro numero e sull’organizzazione della logistica. L’inclusione dei trasporti nazionali in un secondo sistema di quote di CO22a partire dal 2027, deve agevolare questa transizione verso una mobilità a basse emissioni di carbonio che passa anche attraverso il ripensamento dell’organizzazione della mobilità a livello territoriale.
Avremmo voluto che i candidati si esprimessero sulle condizioni sociali ed economiche che consentono l’emergere di questa mobilità a basse emissioni di carbonio che avrà un impatto sui nostri stili di vita.
Progressi nell’edilizia, nella rotazione agricola
Per puntare all’obiettivo del -55% sarà necessario consolidare anche le riduzioni delle emissioni nell’agricoltura e nell’edilizia. L’ultimo periodo ha visto un’accelerazione nella riduzione delle emissioni legate all’uso degli edifici (residenziali o professionali), con l’aumento delle bollette a seguito del conflitto ucraino, ma anche grazie alla diffusione delle pompe di calore i cui effetti si aggiungono a quelli dell’energia termica ristrutturazioni di edifici.
In agricoltura, i recenti sviluppi hanno assunto piuttosto la forma di una svolta. Il passato calo delle emissioni agricole, in particolare nell’allevamento del bestiame, è stato un riflesso delle difficoltà economiche dei produttori, molto più che il risultato di politiche climatiche embrionali. La PAC, attraverso la quale passa la maggior parte del sostegno agricolo, ha integrato solo marginalmente le questioni climatiche attraverso eco-condizionalità. Sotto la pressione del movimento degli agricoltori, l’Europa si è allontanata dagli aspetti agricoli del Green Deal, privilegiando lo standard rispetto agli strumenti di sostegno economico o finanziario.
Al di là delle formule incantatrici sulla sovranità alimentare o sull’agroecologia, c’è un urgente bisogno di ricostruire la PAC per garantire la resilienza dell’agricoltura europea di fronte ai cambiamenti climatici e ridurre le sue emissioni. Ciò è particolarmente vero in Francia, dove l’agricoltura rappresenta il 20% delle emissioni nazionali, rispetto all’11% nell’UE nel suo insieme.
L’indebolimento del bacino di assorbimento del carbonio delle foreste
Per quanto riguarda le emissioni lorde, l’UE è nella giusta direzione, con un grosso svantaggio per l’agricoltura, ma non al ritmo giusto. L’abbiamo appena visto. Questa non è l’unica leva da mobilitare per raggiungere l’obiettivo di riduzione del 55%. Ciò comporta anche la realizzazione del sequestro della CO22 atmosferico grazie alle foreste e ad altri pozzi di carbonio fino a 310 milioni di tonnellate (Mt) di CO2 nel 2030 (34 Mt per la Francia). Tuttavia, in termini di sequestro di CO2non è il ritmo ad essere insufficiente, ma la direzione seguita ad essere cattiva.
La capacità di assorbimento dei pozzi naturali di carbonio dell’UE ha perso poco più di 100 Mt negli ultimi dieci anni ed è stata dimezzata in Francia. La superficie delle aree forestali continua ad espandersi, ma la crescita degli alberi è indebolita dai cambiamenti climatici: siccità, tempeste, incendi e soprattutto l’aumento di specie invasive che diffondono nuove malattie. Come nel caso dell’agricoltura, c’è un urgente bisogno di costruire politiche pubbliche che proteggano la capacità dei serbatoi di carbonio delle foreste a fronte di condizioni climatiche più rigide.
La partita Francia/Germania
Nel quadro definito a livello europeo, gli Stati membri possono perseguire strategie diverse. Ci sono lezioni da imparare da questa diversità, come illustrato dai casi di Francia e Germania in materia energetica.
La transizione energetica richiede un rapido aumento della produzione di energia elettrica priva di carbonio per sostituire quella proveniente dalla combustione di energia fossile e per far fronte all’elettrificazione degli usi. La Germania ha scelto di farlo ritirandosi dal nucleare e investendo massicciamente nelle energie rinnovabili. Per alcuni, questa strategia è un vicolo cieco che porta ad un “risveglio del carbone”. Per altri è la prova che le rinnovabili sono “la soluzione”.
Diamo un’occhiata ai fatti. Nel 2023 la Germania emetterà ancora 8 tonnellate di CO2 equivalente2 pro capite, quando la Francia scese a 5,5 tonnellate. La differenza deriva principalmente dalla produzione di elettricità con emissioni molto inferiori in Francia, dove tre quarti della corrente è fornita dalla flotta nucleare.
Ma la Germania sta riducendo le sue emissioni molto più rapidamente, che nel 2023 scenderanno del 56% rispetto al livello del 1990, rispetto al solo -30% della Francia. Il divario deriva principalmente dal forte calo delle emissioni del settore elettrico tedesco, dove il carbone fornirà solo il 26% dell’elettricità nel 2023, rispetto a quasi il 50% di 10 anni prima, grazie allo sviluppo accelerato delle energie rinnovabili. Non vi è quindi alcuna ripresa del carbone in Germania, contrariamente all’opinione diffusa in Francia.
Tuttavia, la scelta di rinunciare prioritariamente al nucleare ha un costo elevato per il clima, perché rallenta il disinvestimento dal carbone. La chiusura di otto reattori in seguito al disastro di Fukushima nel 2011 ha comportato un maggiore utilizzo delle centrali termoelettriche fino al 2015. Nell’ultimo periodo, la chiusura delle ultime centrali nucleari (totale da aprile 2023) ha pesato sull’offerta di energia carbon-free elettricità in Germania e ha contribuito al recupero temporaneo delle emissioni del settore elettrico nel 2021 e nel 2022.
Se la Germania avesse eliminato l’energia nucleare in modo più graduale, massicci investimenti nelle energie rinnovabili avrebbero consentito un calo ancora più rapido delle emissioni di CO2.2.
L’esempio tedesco ci mostra quanto sia importante, nel dibattito sul nucleare, distinguere le scelte riguardanti l’utilizzo della flotta esistente da quelle riguardanti il nuovo nucleare. Elementi da inserire nel dibattito al di qua del Reno, se un giorno le scelte energetiche verranno discusse in Parlamento come esplicitamente previsto dalla legge.